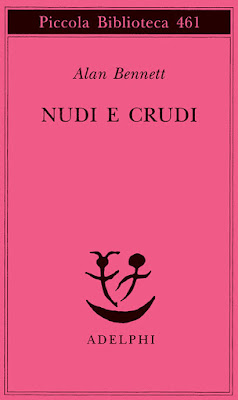Osservatore attento e curioso, fine indagatore nonché gentleman, esperto di analisi sociale, figlio illustre della sua epoca. Giacomo Leopardi (1798-1837) è stato anche questo. Nei "Pensieri" (originariamente inseriti nelle "Opere minori approvate" compilate dal Moroncini nel 1931) raccolti e curati dall’emerito Cesare Galimberti (1928), c’è il Leopardi quotidiano, mondano, che guarda i suoi simili e li descrive raccogliendoli in tipi: v’è il mascalzone, il cittadino, il malato, il rustico, il giovane, l’ignorante, il virtuoso, il ricco, il timido, il celebre, il misantropo, il povero. E spesso ogni osservazione leopardiana va a confrontarsi con l’archetipo donnesco. È superbo Leopardi quando afferma, nel XXIV pensiero, che «chi vuole innalzarsi, quantunque per virtù vera, dia bando alla modestia. Ancora in questa parte il mondo è simile alle donne: con verecondia e con riserbo da lui non si ottiene nulla» (questa citazione verrà utilizzata da Carmelo Bene come epigrafe al suo "Sono apparso alla Madonna" del 1983) oppure quando nel LXXV sostiene che «il mondo è, come le donne, di chi lo seduce, gode di lui, e lo calpesta». Il recanatese, assurto ad emblema del romanticismo ottocentesco, mostra in queste pagine il suo volto meno aulico; capriccioso e campanilistico, Leopardi afferma nel I pensiero che «il mondo è una lega di birbanti contro gli uomini da bene, e di vili contro i generosi», e nel IC che «io conosco città di provincia colte e floride, che sarebbero luoghi assai grati ad abitarvi, se non fosse un’imitazione stomachevole che vi si fa delle capitali, cioè un voler esser per quanto è in loro, piuttosto città capitali che di provincia». Negli ultimi lustri, la cultura italiana sta riconoscendo a Giacomo Leopardi, con colpevolissimo ritardo, le virtù poetiche che gli sono proprie e che erano invece note ai più lucidi estimatori del buongusto italico. Non solo l’opera e il pensiero leopardiani, bensì la sua stessa esistenza fu l’emanazione artistica del vivere romantico in un tempo in cui l’illuminismo stava passando le consegne al nazionalismo tanto che l’Italia, patria par excellence del conte, se per il volgo era soltanto un vago sentore, ad un cor gentile - genuinamente italiano - appariva già chiara ed identificabile.