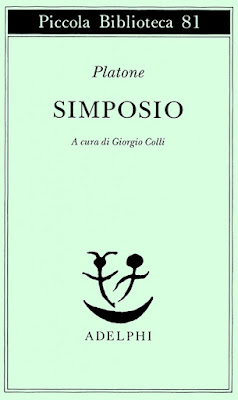«Cresce il deserto: guai a colui che nasconde deserti!». Dunque: che non presenta segno di vita e di attività umana. E come si fa a desertificarsi? Chi può essere considerato un deserto? In definitiva, cosa significa deserto e che valore ha? La maggior parte delle persone non comprende, perché non riesce a penetrare l’apparenza delle cose e delle parole. Questi individui sono essi stessi deserti, perché non hanno innaffiato la propria vita, l’hanno lasciata essiccare al sole cocente della modernità, della borghesia e del nulla intellettuale. Hanno aderito al patto implicito tra la mondanità e la propria individualità: non hanno saputo trovar altra soluzione se non quella di accettare il contratto, chinando la testa allo stato, alla famiglia, all’amore, a Dio, alla morte, a se stessi e agli altri. Dialogare con essi equivale a non parlare: non ci si può attendere alcun tipo di pensiero autonomo, in loro ogni cosa è artefatta, stereotipata, mutuata di poco dal sentire comune. E allora catalogano i sentimenti e le persone, credono di vivere allineati a idee e ideali, inesistenti per definizione. Queste persone sono sempre alla moda, nel senso che tentano di adeguarsi variabilmente nel tempo ai modi di vivere. Ma non hanno altro tempo se non quello che è stato concesso loro. Poi vi sono alcune persone che capiscono le cose e le parole, ma non riescono ad analizzarle perché il più delle volte difettano della cultura necessaria ad imbrigliare tale comprensione. Questi sono deserti inconsapevoli: spesso finiscono ai margini della società e non riescono a penetrarne il senso estremo. Più spesso diventano artisti. Agognano, in cuor loro, di uscire il prima possibile dalla vita, di smetterla di chinare il capo, di accettare la comune vivibilità; purtroppo non riescono a trovare risposte soddisfacenti al perché e al come, tanto da incamminarsi su strade che la civiltà stessa reputa deprecabili, estreme, criminali, fatiscenti. La società civile sa che quei sentieri portano al suo disfacimento e dunque risponde bandendoli; essa preferisce l’accettazione supina delle regole, l’abbassamento della coscienza umana alla più totale fedeltà. Ma una parte di questi individui si dedica all’arte, sperando che essa possa guarire il male che li affligge e, anche se nel lungo periodo la cura non sortisce gli effetti sperati, è questa élite a regalarci le cose migliori dell’umanità. Infine v’è la sparuta minoranza di coloro che comprendono le cose e le parole così a fondo da desertificarsi consapevolmente. Questi sono i più puri, quelli che hanno inteso quale fregatura vi sia dietro l’esistenza umana. A forza di scavare nel fondo delle cose hanno raggiunto l’argilla, sono arrivati all’infertile - al deserto, appunto. In essi non c’è più traccia di emozione alcuna, non c’è passione od ambizione, non hanno rispetto o amore, semplicemente hanno cancellato qualsiasi concetto dalla propria coscienza. Sono liberi. I più temerari di essi individuano in questa nuova ed assoluta libertà una nuova religione, dunque nuove catene, nuovi riti e liturgie, preghiere e confessioni, insomma un nuovo dio cui sottostare. La ricerca del senso non ha mai fine: giunti all’apice della verità scoprono che ce n’è sempre un’altra, più alta e accecante, perniciosa quanto doverosa. Sanno che questa ricerca non avrà mai fine e la maggior parte di questi esseri impazzisce per troppa verità. «Ma nel deserto più solitario accade la seconda metamorfosi: lo spirito divien leone che vuol conquistar la libertà ed esser signore nella sua solitudine». L'evangelo e la bibbia nietzschiane - "Umano, troppo umano" (1878) e "Così parlò Zarathustra" (1883) - rappresentano il tentativo di redimere questo deserto, proprio perché siamo tutti deserti, qualunque sia la nostra capacità di intendere il mondo. Sia che lo accettiamo nella sua banale rotondità, sia che lo addestriamo diventando superuomini, esso vincerà comunque, rivelandoci puntualmente la nostra inadeguatezza di fronte allo specchio. Non serve dunque lottare, men che meno comprendere, e non è poi così necessario vincere. Ad esser sinceri, non vale la pena vivere.
Friedrich Nietzsche (1979), Umano, troppo umano. Volume primo, trad. di S. Giametta, Adelphi, Milano, pp. 329
Friedrich Nietzsche (1976), Così parlò Zarathustra. Un libro per tutti e per nessuno, trad. di M. Montinari, Adelphi, Milano, pp. 425